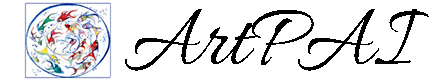Muri e Corridoi, lavorare in gruppo con rifugiati siriani.
Muri e Corridoi, lavorare in gruppo con rifugiati siriani. Gruppi transculturali di supporto psicosociale a rifugiati siriani giunti in Italia grazie ai «corridoi umanitari», re insediati dai campi profughi del Libano
Scritto da:
Carola Palazzi Trivelli e Silvia Torresin
febbraio 2017
------
Descriviamo l’esperienza di un gruppo transculturale, non psicoterapeutico, piuttosto di sostegno ed accoglienza al trauma della migrazione, teso a favorire una più veloce integrazione.
Parliamo di un gruppo composto di persone siriane, giovani e mature, donne e uomini, talvolta anche bambini, seduti in cerchio con una mediatrice culturale di lingua araba, una conduttrice di lingua italiana ed un’osservatrice silente.
In questo gruppo si parla arabo, e la mediatrice traduce in italiano, mediando tra le culture e tra differenti codici linguistici ed affettivi. Se nel gruppo si parla di legami con il paese d’origine, la Siria, attraverso la madrelingua-arabo, la mediatrice (marocchina, dunque parlante l’arabo ma non siriana) restituisce nel gruppo un’idea comprensiva e comprensibile ma leggermente dissimile da quella originariamente espressa: si può discutere cercando di capirsi.
Nel gruppo si parla continuamente di violenze subite, come singoli e come cultura d’appartenenza. Violenze della guerra, violenze delle separazioni obbligate, infine violenze dell’assoggettamento e dell’adesione culturale.
Si parla anche di legami, familiari ma soprattutto culturali, quest’ultimi contengono i legami sociali e familiari e le convinzioni religiose, ma non solo.
Sono legami violenti, in quanto hanno forza, sono raccontati con grande forza, e possono trattenere (e spesso trattengono) dall’elaborazione del trauma.
Trauma, inteso come esperienza di rottura dell’involucro psichico, accaduta spesso in modo violento, che impedisce, o può impedire psichicamente, di ridare un senso, un progetto alla propria vita distrutta.
Il legame è violento perché è eccessivo, (vis etimologicamente nella nostra cultura: ciò che vince, opprime, distrugge) e perché è illusorio, contiene ricordi illusori, di un mondo che non c’è più. Il legame è dunque, in questo senso, irreale.
Raccontiamo chi sono queste persone e come mai si trovino ad accettare, con piacere e costanza, di partecipare ad un gruppo che nasce comunque da un’idea europea di condividere per soffrire di meno. A questo proposito ci siamo interrogate se anche quest’idea di gruppo non sia già una violenza, che lega, opprimendo. Ci siamo risposte, per il momento, di no.
Le persone partecipanti al gruppo sono siriani giunti in Italia (e dunque in Europa) in fuga da guerra e distruzione nella loro Siria dove sono nati e cresciuti. Arrivano attraverso “corridoi umanitari” che partono da campi profughi, soprattutto in Libano, ma anche in Palestina, per qualcuno.
Dunque siamo di fronte a persone doppiamente migranti, che due volte almeno hanno lasciato ciò che erano e ciò che avevano, dopo aver assistito a massacri innumerevoli. Forse, doppiamente traumatizzate. Qui trauma nell’accezione dibattuta da Beneduce (2010) che dice, a pag, 25 : “concetto-cerniera: tra le dimensioni dell’inconscio e quelle della storia, tra conflitti individuali e drammi collettivi, tra esperienze private e significati culturali. Guardare a tale nozione secondo una prospettiva antropologica, o meglio: genealogica, significa dunque esplorare dettagli, sviluppare analogie fra ambiti in apparenza lontani, coglierne l’espressione all’interno di particolari congiunture storiche”.
Facciamo nostra quest’affermazione in quanto non di trauma curabile in senso psicoanalitico si tratta, né di traumi dovuti a situazioni d’urgenza, e neppure in senso stretto di traumi da torture, ma in qualche modo da traumi da assoggettamento, da massacri culturali e familiari, ripetuti su più generazioni, generazioni talvolta presenti nel gruppo, talvolta ricordate, come fratelli, mamme, figli perduti, amici cari.
Persone, i siriani di cui ci occupiamo, che hanno migrato non con un progetto, ma in quanto cacciate dalla loro terra d’origine.
Vi sono due parole arabe con suono molto simile ed etimologia (lo abbiamo imparato nel gruppo) affine che esprimono il migrare:
- majareen (i migranti che scelgono di emigrare )
- mohajira (i migranti costretti a farlo).
Queste parole hanno la stessa radice e il concetto comune sta nell’essere stranieri, estranei nel paese di arrivo.
Il corridoio umanitario, che consente di non essere clandestini, di ottenere subito lo status di rifugiato, di poter abitare in una casa attrezzata e non nel centro di identificazione (ed espulsione), di imparare l’italiano, di avere assistenza sanitaria per sé e per i propri familiari, un pocket money per un po’ di mesi, riporta costantemente alla casa perduta, in Siria. Quella casa, letteralmente, molte volte non c’è più. Se la casa è quel luogo, come viene definito evocativamente in Papadopoulos e come abbiamo l’occasione spesso di riscontrare nei racconti del gruppo, “dove, quando devi andarci, devono accoglierti” o come “qualcosa che comunque non devi meritarti” (cfr. Papadopoulos, p. 63), la cui presenza vale a dire è indiscutibile, è pur vero che essa è ora persa, danneggiata o distrutta. Nei partecipanti al gruppo questa trasformazione della casa vissuta in casa distrutta si traduce in un senso di pericolo interno che può essere celato anche a se stessi ma che nei racconti trapela .
Il corridoio attraversa il pericoloso mare e le leggi europee, tiene al riparo dalle bombe e dagli annegamenti, ma non ripara dal sentirsi stranieri e dal rimpiangere costantemente ciò che si è perduto. Il confronto con quel che si ritrova qui e ciò che si è perduto è costante. “La Siria è come una madre per un figlio”, “Essere cresciuti da una zia non è lo stesso che essere cresciuti da una madre” (proverbio arabo). E quando il rimpianto è troppo forte, forse violento :”Meglio esser lasciati cadere che stare così, come tenuti per i capelli, sospesi, come quando scendi in un pozzo a prender l’acqua, e la corda per tirarti su ti si stringe intorno al collo”. Come congelati, abbiamo commentato. Come in alcune fasi della schizofrenia, abbiamo pensato. E sempre e comunque stranieri, estranei: questo è il vissuto.
Per Devereux, la rinuncia alla propria identità e l’istinto a costruire una falsa identità diventa per lo straniero la principale difesa psicologica dal pericolo dell’annientamento. Noi vediamo in questo gruppo circolare il costante vissuto di sentirsi obbligati ad adattarsi ad un mondo a cui non si appartiene e da cui semmai ci si deve difendere in qualche modo. Dall’assoggettamento culturale della guerra all’adesione culturale al paese d’adozione, le resistenze provocano una struggente nostalgia.
Il legame nostalgico con il paese è violento e disorientante: non solo la casa è distrutta ma anche il paese sta scomparendo o sgretolandosi: se il territorio esiste già solo nelle parole che lo stanno ricordando, si attenua anche la possibilità di attingere da quella rappresentazione simbolica come dimensione originaria e nutritiva che darebbe forza all’identità. Che, forse, nel gruppo si può ri-trovare.
Nel gruppo ricordando i massacri e la Siria di prima della guerra piangono solo le donne, non perché gli uomini elaborino di più, ma in quanto “piangere, per un uomo, è come una montagna che si divide” (altro proverbio arabo). Gli abitanti della Siria, per di più, appartengono ad una cultura millenaria, ed erano abituati a condividere spazi e riti con cristiani, ebrei, drusi, musulmani di diverse convinzioni, e gente comune.
Per sopravvivere psichicamente bisogna dunque abituarsi a stare “come in un tornado, come se passassero costantemente nuvole nere sul proprio capo”. E per di più i partecipanti al gruppo hanno già migrato una volta, dalla Siria dei massacri ai campi profughi dove avevano tentato di ricostruire e di ricostruirsi, ma “quando in casa tua gocciola dal soffitto gocciola piano, se cambi casa l’acqua passa forte e finisce per travolgerti” (sempre proverbio arabo). Si dirà: “hai accettato di far parte del corridoio umanitario, ti hanno proposto un contratto, tu l’hai firmato”….ma “cosa ti ha fatto accettare questo amaro?” “Qualcosa di ancora più amaro”. Se passa il pericolo esterno non è invece sicuro che passi quello più insidioso, interno.
In questo continuo parlar per metafore, ci siamo chieste se il corridoio, che umanitariamente protegge e salva dalle bombe, dai massacri, dai muri d’acqua in cui viaggiano i barconi sovraccarichi, fosse una metafora salvifica ed utopica. Purtroppo il corridoio presuppone una casa e la casa Siria è distrutta, insanguinata, e nella casa nuova, in Italia, ci si sente stranieri, vivi sì ma congelati, tenuti su per i capelli, accolti ma al tempo stesso respinti. Inoltre, e qui sta la violenza del legame, che può inficiare l’obiettivo dell’integrazione ed anche quello, psichicamente forse più rilevante, dell’accoglienza dell’angoscia, ciò che si è lasciato, obbligatoriamente, è idealizzato, perfetto senza tempo, proprio come alcuni ricordi d’infanzia. E ciò che si è portato con sé non può essere diviso da quel vissuto di pericolo interno, sempre in agguato, legato alla casa. E’ impossibile accettarlo: perfetta e senza macchia è la cultura d’origine, mite e generosa con i poveri e i bisognosi, dolcissimi sono i cibi delle feste, allegre le canzoni, millenaria la cultura, di sostegno, sempre, il gruppo familiare allargato, in tutte le fasi della vita, dalla nascita all’invecchiamento, alla malattia alla morte. Il ricordo di ciò che si è perduto, e qui naturalmente non si ritrova, è potentissimo, di grande forza, violento nel suo rimpianto. Si notano le differenze con disgusto, con disillusione, e l’idealizzazione del là ed allora ritorna ad ogni incontro, alla ricerca dei colpevoli russi, americani, iraniani, sauditi, finanziatori del trauma collettivo ed individuale. Elementi esterni quali i cellulari o le lavatrici in tutte le case, che omologano sulla base di ciò che si ha, affascinano, rendono più semplice la vita quotidiana, assimilano nel senso di rendere (superficialmente) simili, di togliere almeno apparentemente quella costante sensazione di estraneità dell’essere stranieri nella nuova patria, senza toccare ciò che davvero si è. Essere assimilati vuol dire rinunciare ai propri usi, costumi e modi di pensare e sentire in favore della cultura ospitante. Difficile, faticoso, angosciante è, diversamente, un cammino di integrazione, dove nessuna cultura sia di dominio o sopraffazione, annientamento dell’altro, ma sia un legame nuovo, non violento, non idealizzato ma sereno: zia e madre allevano insieme. Ciò accade nel gruppo, secondo il modello dello scambio culturale (cfr. Bramanti D., 2011).
Il gruppo transculturale dove si parla la lingua madre araba ma anche la lingua zia italiana diventa così il vero corridoio per passare da una casa all’altra, sentendosi, alla fine del percorso, non più stranieri sempre e neanche costantemente assenti dovunque si abiti, che può cercare di ridare un senso alla propria esistenza traumatizzata. (cfr. A. Sayad, “doppia assenza”: il vissuto di sentirsi assenti, stranieri, sia nella società di origine che in quella di arrivo è il principale rischio per l’integrità dell’identità di ogni migrante).
Nel gruppo, intendiamo la parola integrazione come parola critica e problematica, che va usata in quanto è nella consuetudine del linguaggio dell’accoglienza ma che anche suscita inevitabilmente una dinamica di potere in chi accoglie e in chi viene accolto. In quanto tale, questa parola è da noi interrogata.
Per di più la parola integrazione non è traducibile in arabo, mentre nel mondo arabo traducibile è senz’altro la parola “rifugio” nel senso di luogo intermedio dove si viene accolti e si ha sollievo. Nel gruppo la parola “integrazione” deve essere articolata con un giro di parole, dalla mediatrice culturale araba (marocchina).
Il gruppo non può integrare nel senso idealistico di restituire l’integro perduto, né personale, né culturale.
Pur essendo questo un gruppo non psicoterapeutico ma di sostegno, esso ci mostra come l’ideale di integrità presente in tutti, anche nel conduttore, che accoglie, debba riuscire a convivere con ciò che accade davvero, dinamicamente. Per far funzionare il gruppo bisogna con-vivere nell’integrazione: rendendo espliciti i modelli culturali italiani/occidentali, e togliendo dall’implicito i modelli culturali d’origine. Integrando mondi e tradizioni differenti, bisogni vecchi e nuovi. Articolando la geopolitica di chi giura la guerra e di chi promette la pace. Ma anche, non secondariamente, bisogna con-vivere nell’integrazione nel senso di ricomposizione delle parti frammentate, frantumate, divise, angosciose, dell’identità, in mutamento, di ognuno.
Bibliografia
Andolfi M., a cura di (2005), La mediazione culturale. Tra l'estraneo e il familiare, Franco Angeli, Milano.
Beneduce R., (2010), Archeologie del trauma. Un’antropologia del sottosuolo, Laterza, Bari.
Bramanti D., a cura di (2011), Generare luoghi di integrazione. Modelli di buone pratiche in Italia e all'estero, Franco Angeli, Milano.
Devereux G. (2009, prima edizione 1983), La renonciation à l'identité. Défense contre l'anéantissement, Payot (trad. it prima parte: I Fogli di ORISS, 13/14:185-20, 2000).
Papadopoulos R. K., a cura di (2006), L’assistenza terapeutica ai rifugiati. Nessun luogo è come casa propria, Magi edizioni.
Sayad A. (2002), La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Raffaele Cortina editore, Milano.